Le divagazioni che ho proposto in queste settimane, generate da associazioni e analogie frutto di ricordi e di letture attuali, in realtà sono legate da un filo che le unisce tutte. Da esse infatti trapela il desiderio di un mondo migliore nel quale l’uomo non sia dominatore ma custode. Forse si tratta della nostalgia di un’era non segnata dal peso irriverente verso la Natura e la Terra esercitato da un uomo fuori di testa, che le sfrutta senza rispettare cicli e condizioni necessari per consentire la rigenerazione delle risorse «estratte» e «sottratte» alle generazioni successive. Forse è il segno di una consapevolezza che sta crescendo anche grazie alle sferzate delle più giovani generazioni.
Le divagazioni sono unite dunque da un filo di speranza e fiducia. L’economia può essere cambiata perché non risponde a nessuna forza naturale che governa il pianeta, è solo il prodotto della nostra mente e di come guardiamo il mondo e noi stessi «nel» mondo.
Questa riflessione ci suggerisce di divagare con maggiore profondità sul cambio paradigmatico che le imprese – segnali in questa direzione, abbiamo visto, ce ne sono – sembra voler intraprendere, nella consapevolezza che si possono realizzare molteplici profitti, non solo quelli legati agli utili che restano un indicatore di buon funzionamento (ma non sempre) dell’organizzazione. La divagazione, complice un’altra lettura che mi ha appassionato in queste settimane e su cui vi dirò fra poco, ci riporta indietro nel tempo e ci lascia scoprire che la coscienza sull’impossibilità di andare avanti distruggendo, essendoci bisogno piuttosto di una svolta urgente e radicale, non è poi così recente.
Alcune istituzioni e studiosi avvertivano governi, popoli e business community già negli anni sessanta e settanta dello scorso secolo. Lo facevano anche con molta efficacia, come documenterò nella riflessione, ricorrendo a un linguaggio piano e ben comprensibile. Questa voce, però, faceva fatica a farsi sentire in mezzo al baccano generato dal pensiero neoliberista che abbiamo già criticato intento a costruire la shareholder primacy mentre il mondo, addomesticato dagli effetti soporiferi del mito della «crescita», soffriva le pene di disuguaglianze crescenti.

È una coscienza la cui formazione più matura che si sta oggi consolidando, insomma, ha avuto bisogno di vedere l’orlo del baratro prima di delineare programmi di azione globale, istituzionale, intergovernativa, imprenditoriali e di cittadinanza attiva che ora attraversano il mondo, seppur con intensità diversa.
Questa maturazione può essere sintetizzata così: oggi è difficile trovare qualcuno che si senta di contraddire, lo evidenzia Alberto Felice De Toni in un bel volume scritto a più mani con Gilberto Marzano e Angelo Vianello, questa verità (p. 91):
«le nuove condizioni della Terra sono la conseguenza non calcolata dei nostri modelli culturali, sociali, politici ed economici».
Spiega poco più avanti come tutto questo sia l’esito di una «grande accelerazione». Di che si tratta?
«Consiste nell’allargamento indefinito dell’influenza dell’uomo sulla natura e sull’ambiente, attraverso lo sviluppo di sistemi tecnologici ed economici basati principalmente su alcuni fattori: lo sfruttamento delle risorse naturali come se fossero infinite, il consolidamento di un sistema energetico basato su combustibili fossili […]».

Ebbene bisogna sapere che l’economia che si stava incentivando e osannando, per farla diventare progressivamente il mito sul quale espandere nello stesso tempo ricchezza, disuguaglianza, crisi ecologica, fosse percepita come un grave pericolo era ben chiaro a un gruppo di economisti e altri ricercatori che lavoravano all’OCSE negli anni sessanta. Producevano rapporti voluminosi che invitavano istituzioni e imprese, policy maker e cittadini a cambiare approccio perché sempre più evidentemente insostenibile.
Leader di questo gruppo di studiosi era Cornelius Castoriadis, un personaggio poco conosciuto fuori della cerchia accademica che ha animato, influenzando non pochi pensatori, la riflessione economica e poi filosofica e psicanalitica della seconda parte del novecento.
In quegli anni annotava nel rapporto La croissance de la production 1960-1980. Expérience, perspectives et problèmes de politique économique, pubblicato dall’OCSE nel 1970, che era fondamentale rivedere il concetto di crescita alla luce del benessere sociale indicando come molto complesso «il nesso tra i vantaggi economici e sociali della crescita e i costi che ingenera…[…]».
Nel rapporto, di cui sto leggendo alcuni stralci grazie alla pubblicazione di una scelta accurata di scritti di Cornelius Castoriadis curata da Raffaele Alberto Ventura, si legge (p. 89):
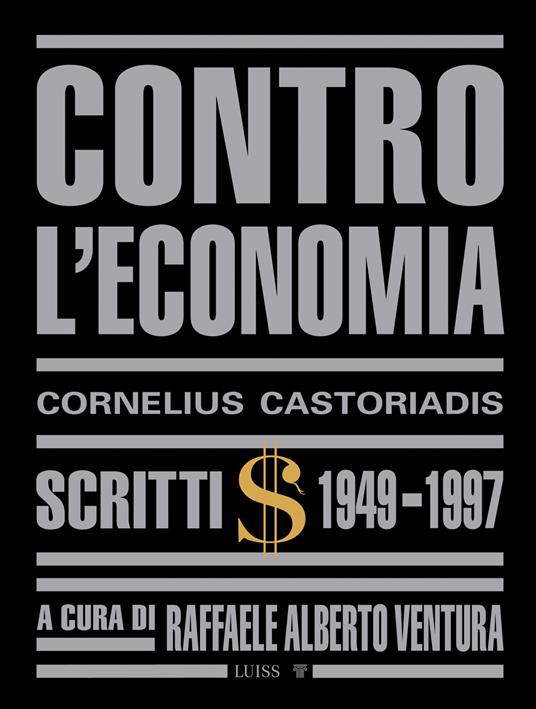
«Poiché la crescita non è un fine in sé stesso ma anzi ha ripercussioni importanti in quasi tutti gli ambiti della vita sociale, gli aspetti non economici e non quantificabili dei problemi devono essere presi in conto nell’analisi, a rischio che questa diventi meno precisa. Gli economisti hanno sempre avuto coscienza che il benessere dell’uomo non si confonde con la produzione di merci […]».
Così già si adombrava l’idea che il PIL fosse metrica di poco conto per farla diventare guida e spada di Damocle della vita dei popoli. E di questo, interessante la sottolineatura di Castoriadis, gli economisti sono stati sempre consci. Perché il fine verso il quale dirigere gli sforzi non può essere la crescita della quale già venivano segnalati i rischi per la salute del Pianeta (p.92):
«Il ritmo e la natura dell’evoluzione industriale e tecnica rischiano, se non si riesce a padroneggiarle, di provocare una degradazione continua e sempre più rapida dell’ambiente […]».
Deve essere chiaro, infatti, che «il processo di crescita suscita, per sé stesso, degli effetti secondari che possono essere indesiderabili, o anche nocivi, sul piano sociale, come in particolare […] l’inquinamento ambientale».
La divagazione invita, dunque, a vigilare per saper leggere con la dovuta attenzione quelli che Papa Giovanni XXIII, nella Costituzione apostolica, con la quale indiceva il Concilio Ecumenico Vaticano II, chiamava «i segni dei tempi». Un’esortazione sempre valida – anche nel presente, perché ve ne sono – a cogliere le voci che gridano ma che vengono silenziate dal rumore del pensiero mainstream e populista che promette senza responsabilità indebolendo giustizia e solidarietà.
La crescita economica non può essere «oggetto di adorazione universale» anche se lo è stato, afferma Castodiaris in una conferenza tenuta a Tokyo nell’ottobre del 1970 ancora come funzionario dell’OCSE, organizzazione dalla quale si dimetterà di lì a poco (p. 97). La crescita e i suoi falsi miti hanno addomesticato governi, soggetti economici e cittadini «finché non hanno iniziato a sorgere dei problemi, definiti con pudore “effetti collaterali non desiderabili”».
Voglio chiudere questa divagazione con un ultimo passaggio profetico che prendo sempre dalla stessa conferenza:
«E personalmente ritengo che sta emergendo un problema ancora più profondo, quello del lavoro in sè, nel suo rapporto con una tecnologia che nessuno controlla e nel suo posto rispetto alla vita umana».
Più di cinquanta anni fa pensava e scriveva queste cose Cornelius Castodiaris. Una divagazione che trovo piena di senso.






Condivido al pieno il pensiero di Castodiaris.
Il solo PIL , la sola crescita non sono indicatori assoluti di benessere quando per benessere si intende la felicità dell’individuo e la capacità di autorealizzarsi nella famiglia , nella società e l’ambiente in cui si vive.
Putroppo la natura miope degli interessi e del nostro modello di sviluppo non premia chi pensa alla sostenibilità e al domani delle future generazioni.
D’altra parte nell’operato di ogni giorno dobbiamo sentirci parte di un cambiamento che per prima deve venire da noi stessi , pensare a risorse limitate alla parsimonia con cui usarle ed insegnare questo ai nostri figli è un nostro dovere, altrimenti saremo solo complici mentre ognuno di noi, nel propriuo ruolo, può fare qualcosa per un domani migliore.
Caro Roberto, grazie per il tuo commento! La palla ce l’abbiamo in mano noi… 🙂
Gab